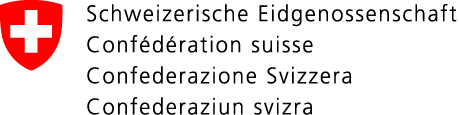Il settore edilizio esplora soluzioni concrete per ridurre la propria impronta di carbonio, in particolare nella produzione di calcestruzzo e acciaio. Christian Paglia, esperto di materiali da costruzione, riscontra progressi significativi, pur evidenziando che numerose norme tecniche devono ancora essere adattate.
Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente, in Svizzera la produzione di materiali da costruzione è responsabile di circa il 10% delle emissioni di gas a effetto serra. Questa percentuale elevata è dovuta soprattutto alla produzione di cemento e acciaio. Per avviare la transizione verso un modello a basse emissioni di carbonio, il settore delle costruzioni (che nel 2021 valeva circa 35 miliardi di franchi, equivalenti al 5% del PIL) si reinventa grazie a nuovi materiali e processi meno energivori, tra cui il cemento LC3. Gli esperti puntano anche sul riutilizzo dei componenti e sulla pianificazione del fine vita degli edifici, come spiega Christian Paglia, direttore dell’Istituto materiali e costruzioni della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).
Quali soluzioni tecniche consentono oggi di ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di calcestruzzo?
Christian Paglia: È necessario concentrarsi su soluzioni che permettano di sostituire in parte il cemento Portland (cemento tradizionale ricco di clinker, materiale la cui produzione emette grandi quantità di CO₂, ndr) con alternative a basse emissioni. Attualmente, il cemento LC3, contenente una percentuale significativa di argilla calcinata e calcare, rimane probabilmente una delle soluzioni più promettenti. L’azienda argoviese JURA ha formulato un cemento di tipo LC3 100% svizzero. I ricercatori stanno esplorando anche altre strade, come l’integrazione nei cementi di residui agricoli (cenere di lolla di riso, strame di fibre legnose) e di rifiuti da incenerimento puliti, a basso contenuto di metalli pesanti. Le norme stabilite dalla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti permettono oggi l’omologazione di cementi alternativi, purché offrano le stesse proprietà meccaniche del calcestruzzo tradizionale. Ad esempio, il cemento di tipo CEM VI integra materiali riciclati provenienti da demolizioni.
Un altro aspetto importante riguarda la riduzione delle distanze di trasporto tramite il ricorso a materiali locali. Questo approccio favorisce anche lo sviluppo di filiere locali di produzione e riciclo, che riducono la dipendenza del settore dalle importazioni.
Anche l’acciaio contribuisce in modo significativo alle emissioni di CO₂. Come renderlo meno inquinante?
Paglia: Uno dei processi più efficaci consiste nel riciclare l’acciaio. A parità di volume, il riciclaggio dell’acciaio da rottami emette circa il 50% in meno di CO₂ rispetto alla produzione da minerale. Oggi, tutto l’acciaio prodotto in Svizzera deriva da questo processo di riciclaggio, che utilizza forni elettrici ad arco anziché forni a carbone, decisamente più inquinanti. Inoltre, per ridurre ulteriormente l’impronta di carbonio occorre favorire il riutilizzo diretto dei componenti in acciaio, evitando il processo di riciclaggio. Questa pratica esiste già, ma la sua applicazione su larga scala è ostacolata da due fattori principali: l’assenza di norme chiare sul riutilizzo e la necessità di valutare lo stato di conservazione degli elementi giunti al termine del loro ciclo di vita.
Anche la pianificazione architettonica riveste un ruolo importante nella riduzione dell’impronta di carbonio del settore. Quali sono le attuali sfide in questo ambito?
Paglia: Costruttori e proprietari stanno iniziando a prestare maggiore attenzione alla fine del ciclo di vita degli edifici, in funzione del riutilizzo dei materiali. Esistono soluzioni per accrescere il potenziale di riutilizzo, in particolare mediante la standardizzazione e la prefabbricazione dei componenti. Tuttavia, il settore non dispone di linee guida chiare per migliorare gli elementi prefabbricati e gli assemblaggi.
Quali opportunità economiche offre la decarbonizzazione alle imprese?
Paglia: Un cambiamento nella tecnologia dei materiali può essere visto come una grande opportunità per valorizzare le risorse locali. In quest’ottica, ad esempio, è possibile dare priorità all’utilizzo di ceneri di legno locali per sostituire le componenti di importazione. Un’altra soluzione consiste nel riutilizzare materiali cementizi fangosi provenienti dalle betoniere: anziché essere smaltiti in discarica, possono essere integrati nella produzione di calcestruzzo per ridurre il contenuto di cemento Portland, principale responsabile delle emissioni di CO₂. Alla SUPSI stiamo attualmente lavorando a progetti in questa direzione, in collaborazione con un produttore di calcestruzzo locale.
Alcuni progetti innovativi hanno permesso di costruire edifici a basse emissioni di CO₂ e di trasformarli in pozzi di carbonio, utilizzando principalmente il calcestruzzo di canapa. Si tratta di soluzioni promettenti?
Paglia: L’uso del calcestruzzo di canapa è interessante per l’isolamento termico e acustico. Per quanto riguarda la riduzione dell’impronta ambientale, il calcestruzzo di canapa offre dei vantaggi, ma risulta anche più difficile da riutilizzare, poiché non presenta le stesse proprietà meccaniche. Bisogna inoltre assicurarsi che la canapa provenga da fonti sostenibili.